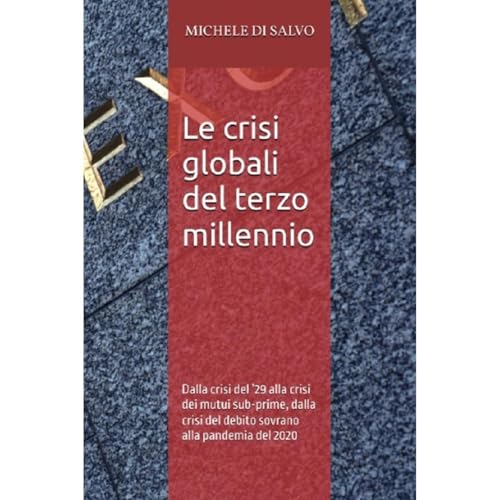
Le crisi del terzo millennio
Dalla crisi del ’29 alla crisi dei mutui sub-prime, dalla crisi del debito sovrano alla pandemia del 2020
No se pudo agregar al carrito
Add to Cart failed.
Error al Agregar a Lista de Deseos.
Error al eliminar de la lista de deseos.
Error al añadir a tu biblioteca
Error al seguir el podcast
Error al dejar de seguir el podcast
Compra ahora por $3.99
-
Narrado por:
-
Virtual Voice
-
De:
-
MICHELE DI SALVO

Este título utiliza narración de voz virtual
Parlare di una crisi come fenomeno storico, quando i suoi effetti e per alcuni aspetti le sue ripercussioni e propaggini sono ancora attuali e immanenti nella maggior parte delle economie mondiali può sembrare azzardato e pretenzioso.
D'altro canto considerare la crisi del 2008 come fenomeno "altro" rispetto alle crisi dei debiti sovrani del 2011 e 2012 è anche questa soluzione semplicistica e a-tecnica.
Serve solo per identificare fenomeni diversi e giustificare una mancanza di analisi unitaria da parte degli studiosi, piuttosto affrettati nel dividere i due fenomeni per non dover ammettere delle connessioni profonde e i molti errori commessi nella gestione della prima quanto della seconda fase della grande recessione globale.
Quella che stiamo vivendo infatti è una fase unica dell'economia mondiale, ovvero il fragile assestamento post recessione della prima crisi dell'era della globalizzazione.
Ciò fa sì che siano evidenti in maniera finalmente chiara e sistematica alcune delle intuizioni e molti dei moniti che venivano dalla parte meno ascoltata degli economisti mondiali quando ci avvertivano che saremmo entrati in un'epoca in cui i normali strumenti monetari, di azione diretta di un singolo Stato, le misure fiscali interne come quelle protezionistiche sui commerci, piuttosto che le azioni sui cambi e sulla liquidità, sarebbero state pressoché annullate, in termini di effetti, e potenziate in termini di costi.
La crisi che abbiamo vissuto, e che nelle sue cause scatenanti ci siamo lasciati alle spalle, altro non è stato che il prezzo pagato a questo ottimismo poggiato sul nulla, a questa visione per cui lasciar fare al mercato avrebbe sempre e solo generato ricchezza.
Ma è anche la concezione filosofica che sta alla base del bisogno di volere sempre e solo crescita, a qualsiasi costo e prezzo, senza darsi un limite e senza un obiettivo.
Quello che siamo chiamati oggi a fare, se vogliamo apprendere qualcosa da ciò che è avvenuto in questi anni, è ripensare il nostro modello complessivo di crescita.
Darci una direzione, e ridare un significato nuovo e possibilmente differente a termini come sviluppo, crescita, valore, ricchezza...
Il problema di fondo da comprendere è che oggi non esistono più "strumenti convenzionali" e conosciuti per porre argine agli effetti devastanti di una crisi economica e che questa può scatenarsi in una settimana e avere effetti decennali. Dobbiamo prendere atto che una bolla speculativa in un determinato luogo poterà certamente a qualcuno molta ricchezza, ma che questa sarà infinitamente inferiore alle risorse globali complessive che si perderanno per tornare, nel tempo, al momento precedente l'esplosione della bolla stessa.
E questo riporta al bisogno di riconsiderare cosa sia per noi valore, e quali debbano necessariamente essere i limiti imposti alla capacità speculativa del singolo (sia un privato, una banca, un gruppo di banche o un singolo paese) in rapporto alla sua capacità di generare reazioni globali.
Riprenderlo in mano nel 2020 – in piena crisi Covid-19 – quando dal 2018 si era tornati a valori sostanzialmente paragonabili al 2007 ha però un significato più ampio rispetto a quello che voleva essere un esame complessivo e un racconto il più possibile divulgativo della prima crisi dell'era dell'economia globalizzata.

